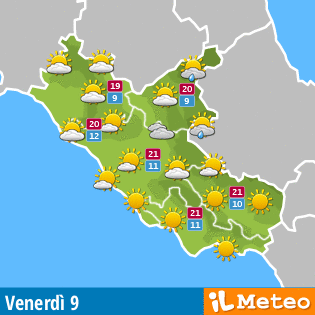Mortadella, fior di latte e pistacchio
Ci avevano detto che c’era un posto speciale, a Grotte Santo Stefano. Un angoletto bucolico (ma vero) nel quale poter mangiare una pizza “che al primo morso sulle braccia ti viene un pelo alto che manco un gatto quando incontra un cane” (riportiamo fedelmente). Ce lo avevano detto tempo fa, alcuni amici, e noi siamo andati a controllare. Perché da prassi, è noto, un giornalista serio deve sempre verificare le fonti.
Bene. Dice: ok, avete cenato a scrocco e ora vi tocca per forza di cose scrivere il classico pezzo-marchetta. No, abbiamo pagato (sia chiaro). Come tutti. Poiché non stavamo lì per lavoro, ma per fame. Per gola. Però un articolo, a digestione avvenuta (e senza sforzi), era proprio il caso di farcelo. Perché al Casaletto la pizza non è una cosa rotonda con sopra la mozzarella. No, al Casaletto la pizza è un’opera d’arte. Un mondo a parte (rima). Un piatto talmente tanto unico che recensirlo è un dovere almeno quanto andare a votare alle Comunali.
Scendiamo nel dettaglio. Innanzitutto la lievitazione, che va dalle 48 alle 72 ore. Avete capito bene, quella pasta viene coccolata anche tre giorni. Alla faccia della prescia (che fece fare i gattini in quel modo) e del mondo che non riesce a decelerare. Ciò permette a chi lavora l’impasto di utilizzare meno lievito. E la conseguenza è che ne puoi buttare in pancia anche due, senza il rischio di passare la notte tra incubi, deliri e siccità stile Sahara.
Avanti. Le farine. Vengono selezionate e rinnovate di continuo. Partendo da un principio monumentale: grani antichi, non modificati geneticamente. Se lo facessero tutti i manipolatori di carboidrati, la celiachia sarebbe un lontano ricordo.
Materie prime. La maggior parte degli ingredienti è roba dell’orto lì dietro. O delle stalle di fianco (maialetto mio). E dove non si arriva si acquista, ma comunque nel raggio di pochi chilometri e solo in posti fidati. Chiude, non in ordine di importanza, la maestria dello chef (che chiamarlo pizzettaro è limitativo), il quale stende a mano senza mattarello.

Il Casaletto dall’alto
Ciò che ne esce, per dire, è una focaccia bianca con sopra adagiati fior di latte, mortadella casereccia e granella di pistacchi. Oppure, nei mesi giusti (perché i peperoni a febbraio sarebbero da ghigliottina) una prosciutto locale più bufala altrettanto e fichi freschi. Si ingurgita l’ultimo triangolino, ci si alza in piedi, ci si abbraccia, e si applaude commossi.
Saremo di parte? Forse. Avremo esagerato? Magari. Il punto però è che in un contesto generale dove la parola “eccellenza” è divenuta una copertura per servirti una cosa decente ad un prezzo vergognoso; quando ti imbatti in una pizza così ti schieri. Con me o contro di me. E noi stiamo dalla parte della mortazza artigianale, che tra l’altro oltre ad essere sincera costa anche il giusto.