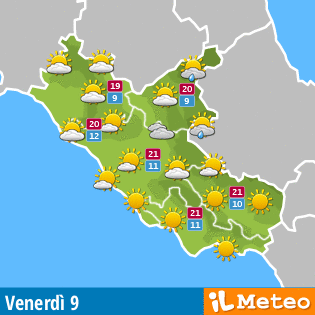Che ci sia grossa crisi, come diceva Guzzanti, è cosa risaputa. Che accendendo la tivù, ascoltando la radio, osservando al bar i classici filosofi da tressette, se ne straparli, è altrettanto evidente. Che il consiglio non dovuto, dato poi da chi meno la soffre, sia: “ragazzi, guardatevi intorno”, non è infine una novità. Così, evitando di uccidere a martellate uno dei tanti (troppi) spara-sentenze del mucchio, magari forse è consigliato di cominciare a guardarsi intorno sul serio. Perfetto. Panorama circostante: ruderi. Campi coltivati (o abbandonati). Case in costruzione. Immondizia. Negozi sfitti (metà dei quali, pochi mesi addietro, occupati da venditori di fumo elettronico). Baracche. Cemento (a profusione). Null’altro? Parrebbe. O meglio, in determinati periodi, soprattutto sul chiudersi dell’estate, spuntano a macchia d’olio interi boschetti gialli. Li si può notare sui bordi delle provinciali. Di lato a torrenti. Su cucuzzoli e in vallate. Non sono margherite, no. Con quelle al massimo ci viene bene la camomilla. La pianta in questione invece, diffusa a perdita d’occhio, è il Foeniculum vulgare. Tranquilli, il piccolo arbusto non spara parolacce. È vulgare, non volgare. E i suoi fiori rappresentano una delle tipicità assolute della zona. Insomma, il protagonista declamato altri non è che il finocchietto selvatico della Tuscia. Quel vaso in vetro, obbligatorio nella dispensa di qualsivoglia nonna, leggero leggero. Che però quando lo si apre emana un profumo incredibile. Unico. Ecco, proprio la mancanza di concorrenza lo rende veramente appetibile.
Fino a pochi anni fa l’idea di commercializzare finocchietto era pura utopia. Lo si faceva in famiglia, d’altronde. Ognuno il suo. Ciascuno la propria ricetta. Il posto adatto dove andarlo a cogliere. E per 365 giorni (minimo) le bistecche avevano un ottimo alleato. Ma volendo anche il pesce, le carni in generale (meglio se cotte sulla brace), determinati tipi di pizza. E poi certi pesti (altro che genovese), più conserve, minestre…
Oggi come oggi comunque il tempo libero è sempre meno. Che poi cosa l’abbia occupato ancora non è chiaro. Il selvatico non si fa più. Che ci vuole un sacco per confezionarlo, tra raccolta, essiccamento, passaggio al setaccio e imbarattolamento. Così lo si compera. A che prezzo? Cento, e in taluni casi anche centoventi, euro il chilo. Mica male. Considerando che il prodotto lo offre la natura. Che si può (anzi si deve) lavorare in semplice regime agricolo. Che serve solo pazienza. E un pizzico di maestria.
Risultati? Le grandi ditte locali lo spingono forte, tra altri miliardi di pezzi forte da bancone. Qualche azienda, pure qui in alta Tuscia, lo smercia on-line. E il consumatore risponde. Bene. Benissimo. Mezza Europa è incuriosita. Mezzo mondo lo prova e lo (ri)ordina. Gli ultimi persino dall’Australia, per i ristoranti.
Insomma, non sarà la soluzione, non sarà la rivoluzione, ma può attutire la botta. E, se proprio dovesse rimanere sul gruppone, per rendergli onore basterà di utilizzarlo sopra la porchetta. Che si digerisce molto meglio dell’aglio (e fa anche bene).